''In tempi di crisi, la gente rinuncia volontariamente ai propri diritti in cambio della promessa di protezione.''
(Naomi Klein, The Shock Doctrine)
Cinque anni dopo l'inizio della pandemia da Covid-19, il mondo appare cambiato in modi che solo oggi cominciamo a comprendere. A metà strada tra l'oblio e la rielaborazione, la società globale si interroga su ciò che è davvero accaduto: al di là delle narrazioni ufficiali, delle teorie complottiste, delle paure e delle certezze costruite sull'urgenza. Ora che l'emergenza sembra alle spalle, possiamo tentare una lettura più lucida e articolata degli eventi che hanno segnato il nostro tempo.
Le domande sulle origini del SARS-CoV-2 restano in parte senza risposta.
Due sono le ipotesi principali ancora in campo: il salto zoonotico naturale, presumibilmente avvenuto in un mercato di Wuhan, e la fuga accidentale da un laboratorio di virologia della stessa città. Nessuna delle due è stata definitivamente provata, ma è significativo che nel 2023 un rapporto del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti abbia ritenuto "con bassa fiducia" che il virus possa essere effettivamente uscito da un laboratorio (Wall Street Journal, 26 febbraio 2023).
Anche la Commissione COVID-19 di The Lancet ha lamentato opacità nelle indagini internazionali e ha raccomandato ulteriori ricerche indipendenti.
Pur non potendo parlare di "creazione artificiale" a scopi dolosi, è ormai legittimo considerare la possibilità di una fuga non intenzionale da ambienti ad alto rischio biologico, alimentata da protocolli di sicurezza inadeguati. Il problema non è solo scientifico: è geopolitico. L'origine del virus è diventata sin da subito una questione di propaganda internazionale, in particolare nello scontro tra Stati Uniti e Cina.
Durante i primi mesi del 2020, la sanità pubblica ha richiesto misure eccezionali: lockdown, chiusure, coprifuoco, obblighi vaccinali.
In Italia il governo ha emanato più di 70 DPCM nel solo 2020. Alcuni erano necessari, altri probabilmente sproporzionati. Ma quello che colpisce, col senno di poi, è la rapidità con cui il principio di libertà personale è stato subordinato a un'emergenza senza chiari limiti temporali.
Lo storico Giorgio Agamben, fin dall'inizio, ha parlato di "stato d'eccezione permanente" e di trasformazione biopolitica della democrazia. Inascoltato, deriso, spesso censurato, Agamben ha posto un tema centrale: cosa succede a una società che affida il governo della vita (e della morte) esclusivamente a logiche tecnocratiche? Il problema non era negare il virus, ma riflettere su come l'emergenza poteva diventare struttura.
Durante la pandemia, la scienza è diventata un campo di battaglia simbolico. Da un lato, il bisogno legittimo di ascoltare esperti; dall'altro, una narrazione ipersemplificata che ha trasformato ipotesi provvisorie in verità assolute. Chi metteva in dubbio alcune misure (mascherine all'aperto, vaccinazioni a tappeto anche su fasce a basso rischio) veniva spesso accusato di essere un "negazionista".
Voci critiche come quelle del premio Nobel Luc Montagnier, del virologo belga Geert Vanden Bossche o dei firmatari della Great Barrington Declaration (come Martin Kulldorff, Sunetra Gupta e Jay Bhattacharya) sono state marginalizzate dal dibattito pubblico, pur proponendo approcci basati su evidenze scientifiche diverse.
In Italia, medici come Giuseppe Remuzzi (Istituto Mario Negri) o Andrea Crisanti hanno a tratti sollevato dubbi, poi riassorbiti nella linea ufficiale.
Non è complottismo chiedersi ''a chi conviene''.
Le multinazionali del digitale e del farmaco hanno registrato profitti record:
- Pfizer ha fatturato oltre 100 miliardi di dollari nel 2022 (di cui 37 dai vaccini COVID);
- Amazon ha visto aumentare i ricavi del 38% nel solo 2020;
- Google, Microsoft, Zoom, Netflix hanno beneficiato della digitalizzazione forzata.
Nel frattempo, piccoli commercianti, lavoratori autonomi, settori culturali e scolastici hanno subito danni irreparabili. La pandemia ha accelerato una transizione sistemica: meno economia diffusa, più centralizzazione; meno spazi pubblici, più algoritmi privati; meno libertà diffusa, più controllo.
Il Covid non ha solo colpito i corpi: ha trasformato la psicologia collettiva.
L'altro è diventato un potenziale veicolo di contagio.
La socialità ha subito una trasformazione radicale. L'uso di app, QR code, identità digitali è diventato parte della normalità.
La scuola, già fragile, si è trasformata per mesi in una piattaforma di videoconferenze.
Gli adolescenti, secondo dati ISTAT, hanno registrato un aumento del 30% dei disturbi d'ansia e del sonno tra il 2020 e il 2022. I ricoveri psichiatrici giovanili sono cresciuti.
Ma di questo, nella fase post-pandemica, si è parlato poco.
C'è un forte impulso collettivo alla rimozione.
Come dopo una guerra, si tende a dimenticare. Ma senza elaborazione non c'è consapevolezza.
Non abbiamo fatto davvero i conti con:
- le decisioni sbagliate;
- le censure a voci critiche;
- gli effetti collaterali della campagna vaccinale (in Italia, segnalati da AIFA oltre 130.000 eventi avversi, di cui 2.500 gravi);
- le contraddizioni nel sistema di comunicazione del rischio.
Molti hanno cercato la verità in teorie assurde: virus creati per il 5G, microchip nei vaccini, elite globali che progettano la riduzione della popolazione.
Ma la realtà è più sottile: il sistema neoliberale ha semplicemente usato l'opportunità per rafforzarsi.
Come scrive Naomi Klein, in Shock Economy, ogni crisi è una finestra per ristrutturare i rapporti di potere. La pandemia è stata questo: un evento reale, gestito secondo logiche economiche, politiche e ideologiche.
Non è stato necessario un complotto: è bastato il meccanismo automatico di un sistema che privilegia profitto, controllo e oblio.
Siamo di fatto entrati in un'epoca in cui:
- la sorveglianza sanitaria diventa permanente;
- l'identità digitale è la nuova frontiera del controllo;
- la crisi climatica verrà forse gestita con la stessa logica emergenziale;
- il dissenso è più difficile, perché viene equiparato a irresponsabilità.
Tuttavia, allo stesso tempo, cresce una nuova consapevolezza:
- la necessità di difendere spazi pubblici, comunitari, non digitali;
- l'importanza di una scienza plurale, non dogmatica;
- il bisogno di ricostruire legami sociali autentici, fisici, empatici.
La "verità vera" sul Covid non è una formula unica, ma un percorso critico. È la capacità di sottrarsi sia al delirio complottista sia alla fede cieca nel potere. È chiedersi: cosa abbiamo imparato, davvero? Come possiamo evitare che la prossima crisi diventi l'occasione per un'ulteriore erosione di libertà?
La pandemia è finita.
Ma la sua eredità è appena cominciata.
Solo chi saprà ricordare, dubitare, rielaborare, potrà costruire un futuro diverso da quello programmato per lui.
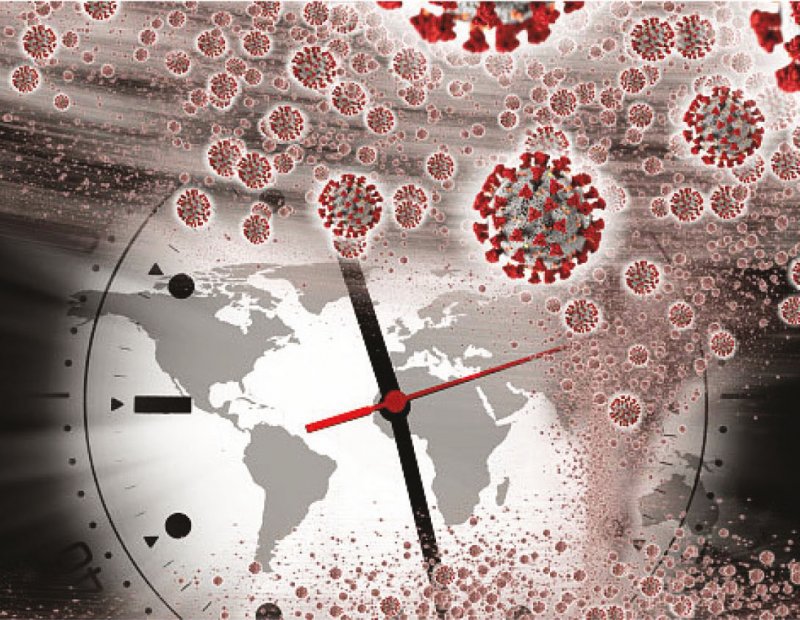



Nessun commento:
Posta un commento