Con la morte di Jorge Mario Bergoglio, passato alla storia come Papa Francesco, si chiude un pontificato che è stato, più che una parentesi, una faglia nella roccia millenaria della Chiesa cattolica. Un pontificato che ha generato entusiasmo e odio, speranza e paura, apertura e resistenza. Francesco non è stato un papa come gli altri: è stato un corpo estraneo, una scheggia impazzita nel meccanismo oliato della conservazione. Ha osato riprendere il Vangelo in mano e chiedersi se valesse ancora qualcosa nella società del capitale assoluto.
"Come vorrei una Chiesa povera per i poveri", disse nei primi giorni del suo incarico.
Era il 16 marzo 2013.
Una dichiarazione che sembrò a molti una boutade francescana, un richiamo poetico. Era invece un manifesto politico.
Nato a Buenos Aires da una famiglia di emigranti piemontesi, gesuita, teologo, pastore di quartieri popolari, Bergoglio portava con sé un'altra esperienza del mondo. Non l'eurocentrismo delle cattedre romane, ma la carne viva del Sud globale, dove i poveri non sono una categoria sociologica ma la maggioranza della popolazione. Fu questo sguardo a rendere subito Papa Francesco un "altro" all'interno della Curia: un papa latinoamericano che parlava di ingiustizia strutturale, di idolatria del denaro, di migranti come "segno dei tempi".
In uno dei documenti a sua firma, ebbe a scrivere: "Così come il comandamento non uccidere pone un limite chiaro per assicurare il valore della vita umana, oggi dobbiamo dire no a un'economia dell'esclusione e della inequità. Questa economia uccide".
Francesco ha tentato di restituire alla Chiesa un ruolo profetico, nel senso biblico del termine: denunciare l'oppressione, stare dalla parte degli scartati. Ha messo sotto accusa il sistema neoliberale globale, ha sostenuto lotte popolari, ha dato voce alle periferie. Ha definito il capitalismo finanziario "un nuovo colonialismo", la fame "uno scandalo che grida al cielo", le armi "uno strumento del diavolo".
Nel 2015, durante l'incontro con i movimenti popolari a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, disse: "Voi siete seminatori di cambiamento. Qui, oggi, voi gridate per la terra, per il lavoro, per la casa. Questo grido io lo faccio mio".
Era una presa di posizione netta, che metteva in imbarazzo vescovi troppo abituati a frequentare i salotti del potere.
Ma è nella pastorale che Francesco ha compiuto la sua rivoluzione più profonda e imperdonabile agli occhi dei tradizionalisti. Ha anteposto la misericordia alla norma, il discernimento personale alla rigidità canonica, l'accompagnamento alla condanna. Ha parlato di accoglienza per le comunità queer, ha aperto spiragli (mai dogmatici, ma pastorali) sul celibato sacerdotale e sulla comunione ai divorziati risposati.
Nel 2016, ha scritto: "Non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in qualche situazione cosiddetta 'irregolare' vivono in stato di peccato mortale".
Apriti cielo.
Cardinali come Raymond Burke, Gerhard Müller, e interi settori della Chiesa statunitense e dell'est europeo hanno iniziato una guerra aperta contro il pontefice. Lo hanno accusato di ambiguità, di eresia, di svendere la dottrina sull'altare del relativismo.
Francesco ha toccato nervi scoperti: il potere economico della Chiesa, la sua complicità storica con le élites, il clericalismo come forma di dominio. Ha criticato senza mezzi termini l'uso del latino come arma identitaria, l'ostentazione liturgica come feticcio, l'integralismo come nostalgia malata.
Ha ridotto i privilegi dell'Istituto per le Opere di Religione, ha avviato una timida ma concreta pulizia finanziaria, ha commissariato ordini religiosi legati al potere e alle connivenze. Ha parlato apertamente di lobby e corruzione interna, di spiritualità deviata, di "mondanità spirituale".
Il paradosso di Francesco è stato quello di essere amatissimo fuori dalla Chiesa e detestato dentro. Per molti intellettuali laici, per movimenti sociali, per non credenti, è stato un punto di riferimento. Ma per larghi settori del clero è rimasto un corpo estraneo, un pontefice che parlava troppo di migranti e poco di dogmi, che non condannava abbastanza l'aborto ma denunciava la fame nel mondo come crimine.
In un'intervista a La Civiltà Cattolica disse: "La Chiesa è chiamata a essere l'ospedale da campo dopo la battaglia. Curare le ferite, curare le ferite... È inutile chiedere a una persona ferita se ha il colesterolo alto o se ha la glicemia. Bisogna curare le sue ferite. Poi potremo parlare del resto".
Le encicliche di Francesco sono documenti di portata storica. "Laudato si'" è forse il testo più potente scritto sul disastro ambientale da un leader religioso: non un trattato ecologista, ma un grido spirituale contro la distruzione della nostra "casa comune". "Fratelli tutti" è un'enciclica contro ogni forma di guerra, di populismo, di chiusura sovranista.
In entrambi i casi, il nemico è lo stesso: l'indifferenza.
Francesco non ha risolto tutti i problemi della Chiesa. Alcuni li ha solo scalfiti, altri li ha aggravati nel tentativo di cambiarli. Ma ha messo sul tavolo i nodi irrisolti: il ruolo delle donne (ancora marginale), la questione del celibato, la gestione degli abusi (che ha affrontato più di altri, ma tra mille ambiguità). Soprattutto, ha imposto alla Chiesa una domanda antica e radicale: "Chi è il prossimo?"
Con la sua morte, il rischio è che tutto questo venga rimosso. Che si torni alla quiete dei dogmi, alla liturgia come rifugio, alla Chiesa come fortezza identitaria. Ma l'impronta di Francesco è profonda. Ha cambiato il modo di essere papa: non più un monarca, ma un pastore. Ha parlato con i gesti, con i silenzi, con la lingua della tenerezza. Ha subito attacchi feroci senza mai restituire colpi.
La sua eredità non è un sistema teologico, ma uno stile. Uno stile che ha riportato il Vangelo al centro. In un tempo in cui la parola "cristiano" è stata sequestrata da ideologie razziste e reazionarie, Francesco ha ricordato che Gesù stava con i poveri, non con i potenti.
E che l'amore è la più pericolosa delle rivoluzioni.
Papa Francesco ha rappresentato, nel cuore della più antica istituzione occidentale, una rottura profonda. Non per sovvertire la Chiesa, ma per restituirle il sapore originario. Il sapore scomodo del Vangelo, quello che non si adatta al potere ma lo contesta. Ha fallito? Ha vinto? Non importa. Ha tracciato una linea. Ora spetta a chi verrà decidere se seguirla o cancellarla.
In un tempo in cui anche la fede è diventata brand, Francesco ha provato a ricordare che il cristianesimo è, prima di tutto, una prassi di liberazione.
E che la misericordia, quando è vera, sa essere più scandalosa dell'eresia.
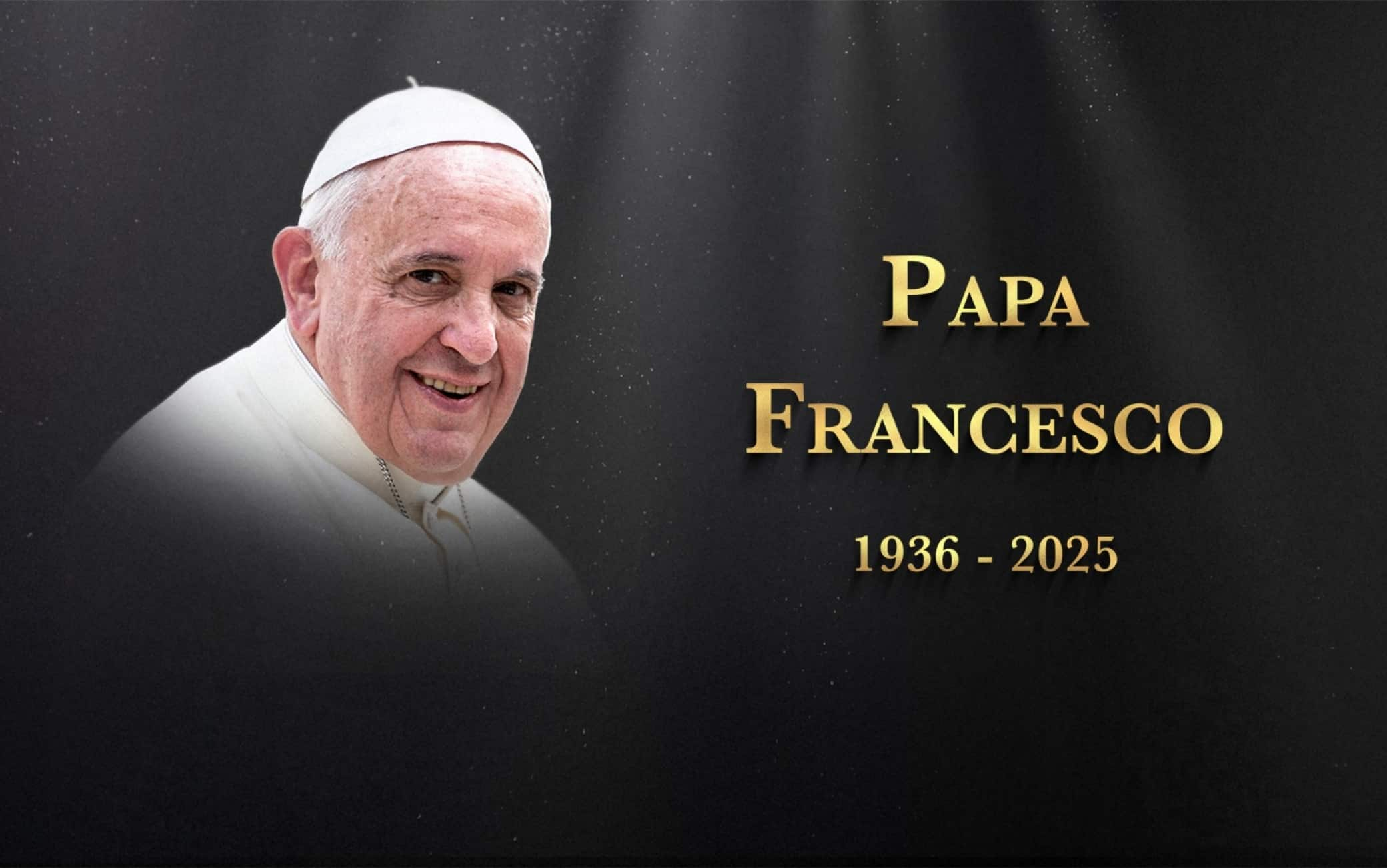


Nessun commento:
Posta un commento