Sono nata il ventuno a primavera
ma non sapevo che nascere folle,
aprire le zolle
potesse scatenar tempesta.
(Alda Merini)
Manicomio.
Secondo la definizione della Treccani: manicòmio s. m. [comp. del gr. μανία «pazzia» e -comio]. – Sinon. di ospedale psichiatrico, usato soprattutto quando esso era concepito, più che come luogo di cura, come luogo di ricovero dei malati di mente: ricoverare, chiudere, internare in m.; andare, finire al m., anche con sign. estens. e fig., diventare pazzo, ammattire (se continua così, finisco al m., finiamo tutti al m.; e, con sign. analogo, mandare al m.); m. criminale e. m. giudiziario, espressioni sostituite nell’uso ufficiale giuridico (1975) con l’attuale denominazione di ospedale psichiatrico giudiziario, istituto in cui vengono rinchiuse, come misura di sicurezza, persone che pur avendo commesso reati sono state prosciolte per infermità psichica, per intossicazione cronica da alcol o stupefacenti, o per sordomutismo non curato.
E’ una parola strana, che cerchiamo di tenere lontana, nascosta, quasi a voler ribadire la nostra estraneità con quelli, con le persone che si trovavano al suo interno.
I rifiuti della società, quelli che con il loro comportamento si allontanavano da quelli che erano i canoni stabiliti del vivere sociale.
Questo era il pensiero comune sino agli anni 70.
E proprio questo pensiero ha consentito che i manicomi, gli ospedali psichiatrici giudiziari, diventassero in tanti casi degli abissi di dolore, quasi una riedizione rivisitata e corretta della peggiore espressione della malvagità umana.
I lager.
Ho avuto recentemente modo di leggere un libro scritto da Alberto Papuzzi nel 1977, “Portami su quello che canta – Processo a uno psichiatra” (Einaudi Gli Struzzi) riguardante il processo nel quale venne imputato il Dottor Giorgio Coda, direttore dell’Ospedale Psichiatrico di Collegno e dell’Ospedale per bambini Villa Azzurra.
Chi era Giorgio Coda, e cosa avveniva esattamente all’interno di quelle strutture?
 |
| Giorgio Coda |
Nato a Torino nel 1924, nel 1943 si iscrisse alla facoltà di Medicina dell'Università di Torino, laureandosi nel luglio del 1948 con una tesi in antropologia criminale. In campo professionale giunsero diversi riconoscimenti: fu nominato medico capo di sezione, l'equivalente del primario odierno, e nel 1963 ottenne la libera docenza in psichiatria. In breve tempo riuscì a conquistare la stima e l'ammirazione di molti colleghi. Divenne vicedirettore dell'ospedale psichiatrico di Collegno e direttore di Villa Azzurra, una struttura per bambini. La società stava mutando, anche se non tutti in campo accademico si accorsero di quel cambiamento. Di quello che avveniva all'interno delle strutture per la cura dei malati psichiatrici la gente “comune” conosceva poco, forse volutamente nulla.
Tutto ciò cambio nel 1970, quando un’assistente sociale, Maria Repaci, del Centro di Tutela Minorile di Torino, inviò un rapporto al Tribunale per i minorenni.
Il 26 luglio dello stesso anno, il settimanale L’Espresso pubblicò una foto che ancora oggi, a distanza di quasi 50 anni, suscita allo stesso tempo ribrezzo e infinita rabbia.
Quella nell’immagine era una bambina di soli sette anni legata, nuda, ad un letto e quella fotografia divenne il simbolo delle condizioni disumane in cui languivano i ricoverati dell'ospedale psichiatrico di Collegno e Grugliasco, operose cittadine alle porte di Torino. La piccola ritratta, nuda, nella fotografia soggiornava nell'ospedale per bambini Villa Azzurra, diretto dall'eminente professor Giorgio Coda. La fotografia fu pubblicata sul paginone centrale del settimanale L'Espresso. Sotto l'immagine angosciosa un titolo sarcastico: Ma è per il suo bene. Nell'articolo che accompagnava il servizio fotografico, il giornalista Gabriele Invernizzi narrò che la bimba sorrise agli sconosciuti che si affacciavano al suo letto.
Iniziò a sollevarsi il pesante velo che sino ad allora aveva coperto le attività del Dottor Coda.
Il trattamento medico, se così vogliamo chiamarlo, consisteva nell'applicazione di scariche di elettroshock durature ai genitali ed alla testa. Queste scariche non facevano perdere la coscienza al torturato ma gli provocavano lancinanti dolori.
Secondo la testimonianza di Giorgio Coda, psichiatra, tale trattamento avrebbe dovuto curare il paziente. La fantomatica cura era chiamata da Coda Elettroshock o elettromassaggio, a seconda che venisse praticato alla testa o ai genitali. Le scariche di elettroshock erano praticate senza anestesia e, quasi sempre, senza pomata e gomma in bocca. In questo modo al paziente saltavano i denti.
Durante il processo, Giorgio Coda ammise d'aver praticato circa 5000 elettromassaggi.
I trattamenti con elettroshock venivano effettuati preferibilmente su alcolisti, tossicodipendenti, omosessuali e masturbatori.
Leggendo il libro di Alberto Papuzzi, si può chiaramente capire quale era il reale sentimento che induceva Giorgio Coda, ed i suoi aiutanti, ad operare tali procedimenti violenti: sia l'elettroshock che l'elettromassaggio non erano strumenti di cura ma, bensì, atroci torture e punizioni.
Utilizzati anche su bambini.
Per comprendere l'orrore, non solo visto con gli occhi di oggi ma anche con quelli del tempo in cui tutto ciò avveniva, va riportata integralmente la testimonianza di un paziente di Giorgio Coda: "Sono stato uno dei massaggiati del dottor Coda... venni sottoposto a due elettromassaggi in pochi giorni successivi che furono per me una terribile tortura... Il trattamento mi fu fatto per punizione, come mi disse il sottocapo degli infermieri...
Tutti gli infermieri mi dicevano che dovevo alzarmi e lavorare, altrimenti avrei subito altri elettromassaggi. Quando il Coda giunse di nuovo al mio letto, gli feci presenti le mie condizioni cardiocircolatorie, ma il Coda non ne tenne conto, cosi come faceva con gli altri. L'elettromassaggio era una vera tortura, come una folgorazione continuata a intensità crescente, che produce una vibrazione terribile al cervello e la sensazione di impazzire, nonché uno scintillamento continuo di luminosità: un veder le stelle. Durante l'applicazione, Coda mi diceva delle parole ironiche: Ti piace questo avvocato? Vedrai che dopo questo lavorerai".
Alcuni suicidi verificatisi negli istituti diretti da Coda fecero nascere il sospetto che potessero essere stati provocati dalla paura della sofferenza dei trattamenti.
Come gli eretici che durante l'Inquisizione, per evitare nuovamente le torture, ammettevano qualsiasi colpa.
Villa Azzurra
Un giorno di luglio del 1974 giunse la sentenza del processo che vedeva Giorgio Coda come imputato: fu dichiarato responsabile del reato ascritto limitatamente ai fatti relativi all'ospedale psichiatrico di Collegno.
Successivamente il difensore di Giorgio Coda ricorse in appello contro la sentenza di primo grado.
Il caso Coda, come molti altri ai suoi tempi, fu interpretato in chiave politica: in questa interpretazione il medico borghese, piccolo piccolo, Giorgio Coda si accaniva contro le fasce più deboli della società.
Ma la storia non termina qui.
Il 2 dicembre 1977, Coda viene gravemente ferito da un nucleo di Prima Linea nel suo studio di via Casalis, a Torino. Il commando entra in azione alle 18,40: in studio, oltre a Coda, il collega Treves e Carla Simonessa, l’infermiera-segretaria. Proprio la Simonessa, dopo aver sentito il citofono suonare, si avvicina al portone: «siamo della polizia, non si preoccupi», sente dire dall’esterno. Quando la donna apre il portone, si ritrova di fronte quattro giovani con le pistole spianate. Uno di questi prende per il braccio l’infermiera e la trascina nel bagno mentre un secondo uomo raggiunge correndo la stanza nella quale Coda visita i pazienti: afferra lo psichiatra, lo incatena al termosifone e lo obbliga a inginocchiarsi. Il breve «processo» al quale lo psichiatra viene sottoposto tocca fatti già emersi durante l’inchiesta della magistratura partita con l’esposto del 1968. Le accuse sono lanciate in modo freddo e la sentenza è di condanna: un primo proiettile si conficca nella spalla destra del medico, un secondo nella sinistra, mentre un terzo va a spappolare il ginocchio. I colpi destinati al medico avrebbero dovuto essere cinque: un probabile inceppamento dell’arma risparmia a Coda gli altri due, che vengono ritrovati inesplosi per terra. Alle 19 il commando è già in strada, non senza prima aver tranciato i cavi del telefono.
I primi soccorsi a Coda vengono operati da un farmacista della zona. Ambulanza e polizia arrivano presto: Coda finirà alle Molinette in prognosi riservata. La modalità del ferimento non è probabilmente casuale. Durante il processo al medico era emerso un episodio, denunciato da un gruppo di assistenti sociali, di un bambino legato a un termosifone e poi liberato con ustioni alle braccia e alla schiena. Le modalità seguite nel ferimento di Coda sono quindi forse da ricercarsi in una logica da «contrappasso».
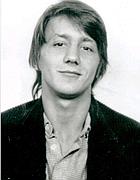 Tra le persone poi finite in carcere grazie alle rivelazioni di alcuni pentiti, vi è anche Albertino Bonvicini.
Tra le persone poi finite in carcere grazie alle rivelazioni di alcuni pentiti, vi è anche Albertino Bonvicini.Nel 1974 Albertino Bonvicini è già stato abbandonato dalla madre, ed è entrato e uscito da sette tra orfanotrofi ed ospedali psichiatrici. In uno di questi, l’Istituto psicomedicopedagogico Villa Azzurra di Grugliasco (Torino), ci finisce perché ha volontariamente inghiottito una biglia durante una lite con alcuni bambini dell’orfanotrofio che lo ospita. Albertino è un bambino irrequieto e così il professor Giorgio Coda lo sottopone a diverse sedute di elettroshock, lo obbliga a lottare con i compagni (fino a quando lo «sconfitto» non cade a terra sanguinante), lo tiene legato al letto o, dopo i tentativi di fuga, al termosifone.
Nel 1971 Albertino viene affidato ai signori Berlanda, una coppia di ex partigiani comunisti torinesi dalla cui casa Albertino cerca più volte di fuggire, calandosi dai balconi, così come aveva fatto a scuola e come cercherà di fare, nel 1973 (a 15 anni, insieme a tre amici) dai poliziotti che lo arrestano dopo la fuga – con incidente - su un’auto rubata dal carcere minorile Ferrante Aporti.
Se Bonvicini viene sospettato è perché la politica era diventata la nuova passione della sua adolescenza. C’è anche lui tra i fondatori del circolo della sinistra extraparlamentare Barabba, c’è anche lui tra gli accusati dell’incendio del bar Angelo azzurro, in via Po, in cui morì lo studente Roberto Crescenzio, rifugiatosi nel bagno.
Albertino Bonvicini finisce in carcere dunque, e ci resta 2 anni e 7 mesi. Lo aiuta un manifesto che aveva scritto e appeso al Barabba molto prima, nel 1978, in cui aveva spiegato con chiarezza la sua contrarietà alla lotta armata aggiungendo appunto «Fate la storia senza di me». Una volta di più, Bonvicini riassume su di sé la parabola di una generazione. Quando esce dal carcere, ha preso la maturità artistica e inizia a immaginare una nuova vita. Va a Londra, in cerca di una sua strada individuale, che nel frattempo però ha incrociato la droga. Quella pesante, degli aghi che infettano e nessuno ancora lo sa.
E così, la decisione di provarci col mondo dell’informazione e diventare prima vicesegretario di redazione a Reporter con Enrico Deaglio e poi collaborare con Giuliano Ferrara a Il testimone.
E' l’ultima grande svolta della sua vita.
Albertino Bonvicini ha contratto l’Aids, che lo ucciderà nel 1991. È un corto circuito totale, vedere in Fate la storia senza di me, il documentario di Mirko Capozzoli allegato all’omonimo libro, le immagini di Bonvicini su Raidue nel 1988, in versione (parecchio autoironica) di «valletto» di Ferrara. Ha l’aspetto davvero più innocuo del mondo, ed è un’ulteriore ironia del destino la sua non troppo lontana somiglianza con Giusva Fioravanti, che a quell’epoca feroce è riuscito invece a sopravvivere. Non può essere un caso che, in Fate la storia senza di me, la voce che legge (alla perfezione) brani del diario di Albertino sia quella di Fabrizio Gifuni, uno dei volti de "La Meglio Gioventù" di Marco Tullio Giordana, film nel quale viene fatto esplicito riferimento al processo nel quale fu imputato Giorgio Coda.
Albertino Bonvicini poteva tranquillamente essere uno dei pazienti che testimoniarono contro questo novello Dr. Mengele.
Un'ultima piccola annotazione per il titolo del libro Portami su quello che canta, processo ad uno psichiatra: deriva da un'affermazione di Coda, il quale avrebbe sentito un malato cantare in un cortile dell'ospedale ed avrebbe deciso di praticargli un elettromassaggio, chiedendo all'infermiere: “portami su quello che canta”.
In questa piccola affermazione possiamo leggere il disprezzo di un uomo nei confronti della malattia mentale e, di conseguenza, della vita umana.
E oggi? Qual è la situazione?
Nel 2011, una speciale commissione del Senato, guidata da Ignazio Marino, senza alcun preavviso, si presenta con una telecamera, presso alcuni ospedali psichiatrici giudiziari,
Ogni parola è superflua.
Ancora una volta la storia non ha insegnato nulla.
Nel marzo 2015, l’ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario ubicato nel popoloso quartiere di Materdei a Napoli viene occupato dagli studenti del CAU, con l’intento di recuperare la struttura e restituirla al quartiere.
Quello che hanno trovato ad accoglierli, una volta entrati, può essere paragonato solo al girone dei dannati dell’inferno dantesco: i segni del tempo e della mancata manutenzione sono evidenti ad ogni angolo.
Ma, ancor più sinistri, risultano i segni di quello che subivano i pazienti qui ricoverati.
Celle di pochi metri quadrati, chiuse da pesanti doppie porte blindate, letti di contenzione saldati al pavimento, sbarre ad ogni corridoio, pile di squallide divise uniformi marroni e scarpe accatastate come in un campo di concentramento, di quelli tristemente noti nella storia del Novecento.
Sui muri, ci sono le poesie di lucida disperazione: ”Mamma come faccio a diventare amico di un insetto?”
Cantava bene Fabrizio de Andrè:
Tu prova ad avere un mondo nel cuore
e non riesci ad esprimerlo con le parole
e la luce del giorno si divide la piazza
tra un villaggio che ride e te lo scemo che passa
e neppure la notte ti lascia da solo
gli altri sognan se stessi e tu sogni di loro
E se anche tu andresti a cercare
le parole sicure per farti ascoltare
per stupire mezz'ora basta un libro di storia
io cercai di imparare la Treccani a memoria
e dopo maiale, Majakowskij, malfatto
continuarono gli altri fino a leggermi matto
E senza sapere a chi dovessi la vita
in un manicomio io l'ho restituita
qui sulla collina dormo malvolentieri
eppure c'è luce ormai nei miei pensieri
qui nella penombra ora invento parole
ma rimpiango una luce, la luce del sole
Le mie ossa regalano ancora alla vita
le regalano ancora erba fiorita
ma la vita è rimasta nelle voci in sordina
di chi ha perso lo scemo e lo piange in collina
di chi ancora bisbiglia con la stessa ironia
"una morte pietosa lo strappò alla pazzia"
(F. De Andrè – Un Matto¬ – Non al denaro non all’amore né al cielo 1971)





Nessun commento:
Posta un commento