C’è un filo rosso che attraversa l’intera parabola politica di Donald Trump, dai primi raduni elettorali del 2015 fino ai processi in corso e alla campagna per le presidenziali del 2024-2025: è la voglia di caos. Non un semplice disordine tattico, utile a destabilizzare l’avversario, ma un disordine più profondo, strutturale, quasi esistenziale. Un impulso a sovvertire, scompaginare, incendiare i codici del discorso pubblico, i rituali istituzionali, la grammatica della democrazia rappresentativa.
Ma da dove nasce questo desiderio di caos? Perché un miliardario, ex volto televisivo, con ogni privilegio possibile, sembra agire come un outsider rancoroso, come un sabotatore sistematico delle élite di cui pure ha sempre fatto parte? La risposta, forse, non va cercata solo nella strategia politica, ma anche nella psicologia individuale e collettiva. Trump, in questo senso, più che un semplice leader, è una lente d’ingrandimento puntata su una certa frattura americana – e occidentale – che serpeggia tra frustrazione, senso di emarginazione e bisogno di rivalsa.
Ogni gesto pubblico di Trump, i tweet furiosi, le accuse paranoiche, il disprezzo per le regole, l’uso spettacolare della menzogna, sembra rispondere a una logica emotiva prima che razionale. Il suo narcisismo è patologico non tanto perché egocentrico (quale politico non lo è?), ma perché vulnerabile. La sua smania di consenso si accompagna a un’ipersensibilità al giudizio altrui.
Ma da dove nasce questo desiderio di caos? Perché un miliardario, ex volto televisivo, con ogni privilegio possibile, sembra agire come un outsider rancoroso, come un sabotatore sistematico delle élite di cui pure ha sempre fatto parte? La risposta, forse, non va cercata solo nella strategia politica, ma anche nella psicologia individuale e collettiva. Trump, in questo senso, più che un semplice leader, è una lente d’ingrandimento puntata su una certa frattura americana – e occidentale – che serpeggia tra frustrazione, senso di emarginazione e bisogno di rivalsa.
Ogni gesto pubblico di Trump, i tweet furiosi, le accuse paranoiche, il disprezzo per le regole, l’uso spettacolare della menzogna, sembra rispondere a una logica emotiva prima che razionale. Il suo narcisismo è patologico non tanto perché egocentrico (quale politico non lo è?), ma perché vulnerabile. La sua smania di consenso si accompagna a un’ipersensibilità al giudizio altrui.
Trump non tollera l’umiliazione.
La stampa che lo critica, i giudici che lo indagano, i repubblicani che non lo seguono fino in fondo: tutti diventano nemici, traditori, da annientare.
Da qui la costruzione di un mondo parallelo, in cui lui è sempre vincente, sempre “il più grande”, sempre vittima di un complotto. Quando la realtà lo contraddice, la realtà stessa viene screditata.
Da qui la costruzione di un mondo parallelo, in cui lui è sempre vincente, sempre “il più grande”, sempre vittima di un complotto. Quando la realtà lo contraddice, la realtà stessa viene screditata.
È un impulso simile a quello che Freud descriveva come rimozione, ma con un’energia distruttiva in più: l’idea che se il mondo non riconosce la tua grandezza, allora è il mondo ad essere sbagliato, e va distrutto, o perlomeno destabilizzato.
Questa dinamica, apparentemente personale, ha trovato una risonanza collettiva. Trump ha captato, amplificato e politicizzato un sentimento di risentimento diffuso tra ampi strati della popolazione americana: la working class bianca impoverita dalla globalizzazione, gli ultraconservatori marginalizzati dal progresso sociale, i complottisti in cerca di risposte semplici in un mondo complesso.
Non è un caso che il suo linguaggio assuma spesso toni apocalittici: “drenare la palude”, “combattere il deep state”, "salvare l’America".
Questa dinamica, apparentemente personale, ha trovato una risonanza collettiva. Trump ha captato, amplificato e politicizzato un sentimento di risentimento diffuso tra ampi strati della popolazione americana: la working class bianca impoverita dalla globalizzazione, gli ultraconservatori marginalizzati dal progresso sociale, i complottisti in cerca di risposte semplici in un mondo complesso.
Non è un caso che il suo linguaggio assuma spesso toni apocalittici: “drenare la palude”, “combattere il deep state”, "salvare l’America".
Dietro queste parole si nasconde l’idea che l’intero sistema, politico, mediatico, istituzionale, sia corrotto, nemico, irredimibile. E quindi, in ultima analisi, da rovesciare.
Anche a costo di evocare, o provocare, il caos.
L'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 è stato forse il momento più emblematico di questa dinamica: non una semplice protesta, ma un tentativo simbolico (e, per alcuni, operativo) di spezzare la continuità democratica. Il fatto che Trump, pur non guidando direttamente l’assalto, ne abbia creato le condizioni narrative e psicologiche è rivelatore. È come se avesse bisogno, al di là di ogni calcolo politico, di vedere il sistema vacillare sotto i colpi della sua narrazione.
Ma perché scegliere il caos? Perché coltivare il disordine come strategia, o forse come necessità? Una possibile risposta viene dalla psicologia sociale: in un mondo percepito come ingiusto e ostile, il caos può apparire paradossalmente rassicurante. Meglio il disordine totale che una realtà in cui si è esclusi o ridicolizzati.
Meglio distruggere il gioco che continuare a perdere.
Trump incarna questo atteggiamento con una coerenza impressionante. Non ha mai mostrato reale interesse per le regole democratiche, per il pluralismo, per la mediazione. La sua leadership si fonda sull’intuizione che una parte dell’elettorato non cerca soluzioni, ma rivalse. Non sogna una società più giusta, ma una vendetta simbolica contro chi "sta sopra".
In questo senso, Trump non è un anomalia, ma il sintomo più visibile di un disagio profondo. La voglia di caos che promuove, e che attrae milioni di persone, non nasce dal nulla, ma da decenni di promesse non mantenute, di disuguaglianze crescenti, di identità ferite. È un grido di frustrazione travestito da rivoluzione.
Trump incarna questo atteggiamento con una coerenza impressionante. Non ha mai mostrato reale interesse per le regole democratiche, per il pluralismo, per la mediazione. La sua leadership si fonda sull’intuizione che una parte dell’elettorato non cerca soluzioni, ma rivalse. Non sogna una società più giusta, ma una vendetta simbolica contro chi "sta sopra".
In questo senso, Trump non è un anomalia, ma il sintomo più visibile di un disagio profondo. La voglia di caos che promuove, e che attrae milioni di persone, non nasce dal nulla, ma da decenni di promesse non mantenute, di disuguaglianze crescenti, di identità ferite. È un grido di frustrazione travestito da rivoluzione.
Trump non è un politico nel senso classico del termine.
È una figura post-politica, o meglio pre-politica: agisce nel registro del mito, dell’archetipo, della rappresentazione. Il suo è un teatro continuo, dove conta più la performance della proposta, più il colpo di scena del compromesso.
In questo teatro, il caos è una risorsa narrativa. Ogni crisi rafforza il personaggio. Ogni attacco lo rende più perseguitato, quindi più amato.
In questo teatro, il caos è una risorsa narrativa. Ogni crisi rafforza il personaggio. Ogni attacco lo rende più perseguitato, quindi più amato.
Ogni caduta è rilanciata come una prova eroica.
È una narrazione ciclica, quasi messianica: Trump cade, viene crocefisso dai media e dalla giustizia, ma risorge, più forte, più puro, più deciso.
La politica, in questa visione, non è il luogo del confronto razionale, ma del culto. E ogni culto ha bisogno di un nemico, di un martire, di un’apocalisse incombente.
La politica, in questa visione, non è il luogo del confronto razionale, ma del culto. E ogni culto ha bisogno di un nemico, di un martire, di un’apocalisse incombente.
La voglia di caos è, in fondo, la voglia di un nuovo inizio, purché sia distruttivo abbastanza da spazzare via tutto ciò che ci ha delusi.
Comprendere la voglia di caos che muove Trump, e chi lo sostiene, non significa giustificarla. Significa riconoscerne le radici, le motivazioni profonde, le logiche emotive. Significa accettare che la politica contemporanea non si muove più solo sul terreno delle idee, ma anche su quello delle ferite, delle paure, dei desideri inconfessati.
Trump, con il suo egocentrismo devastante, non è solo un pericolo per la democrazia americana.
Comprendere la voglia di caos che muove Trump, e chi lo sostiene, non significa giustificarla. Significa riconoscerne le radici, le motivazioni profonde, le logiche emotive. Significa accettare che la politica contemporanea non si muove più solo sul terreno delle idee, ma anche su quello delle ferite, delle paure, dei desideri inconfessati.
Trump, con il suo egocentrismo devastante, non è solo un pericolo per la democrazia americana.
È anche uno specchio distorto e inquietante dei nostri tempi.
E forse, guardare in quel caos significa fare i conti con ciò che la democrazia ha lasciato indietro.


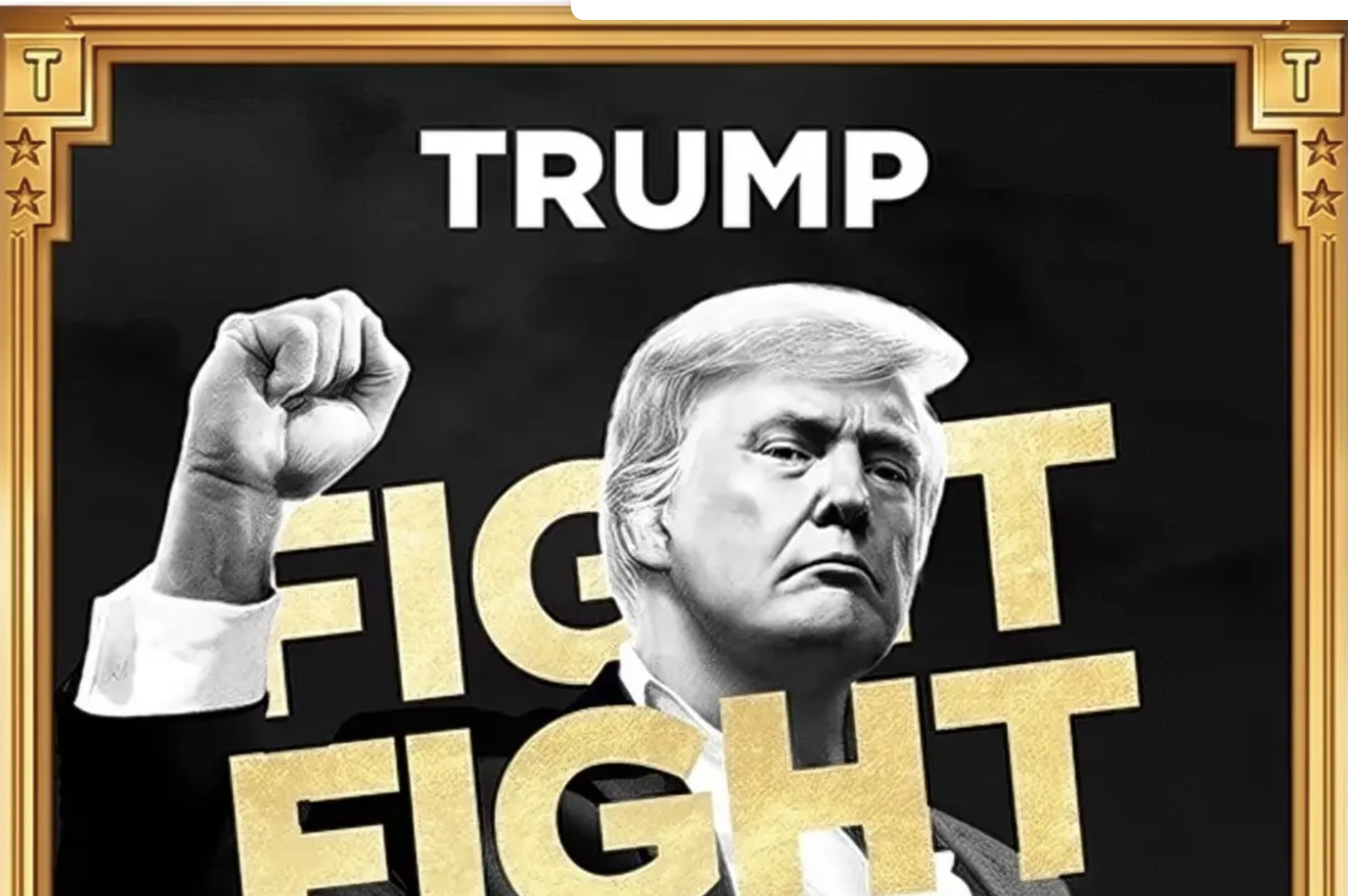


Nessun commento:
Posta un commento