Inauguriamo La biblioteca di Babele, con un libro che è esso stesso una biblioteca impossibile.
Un labirinto di storie, di tempi, di ossessioni e di fantasmi. 2666 non è solo un romanzo: è un campo di battaglia della coscienza contemporanea, un atlante del male moderno, un poema epico e disperato sulla fine della letteratura e sulla sua necessità. Un'opera che sfida la forma, che interroga il mondo, che non fa sconti a nessuno. Un'opera che non si limita a rappresentare la realtà, ma che la attraversa come un taglio.
Uscito postumo nel 2004, 2666 è il romanzo-testamento di Roberto Bolaño, autore cileno che ha attraversato la fine del secolo scorso con la grazia tragica dei poeti maledetti e la lucidità di un cronista metafisico. Composto da cinque parti autonome ma tra loro collegate, il libro si estende su oltre mille pagine ed è stato paragonato a un'opera-mondo, sul modello di Moby Dick o L'uomo senza qualità. Bolaño non lo ha visto pubblicato.
Morì nel 2003, a cinquant'anni, mentre era in attesa di ricevere un trapianto di fegato. Aveva chiesto all'editore di dividerlo in cinque volumi separati, per garantire maggiori entrate ai figli. Ma i curatori decisero di pubblicarlo integralmente, come un'unica entità. Scelta che oggi appare inevitabile: 2666 è un organismo vivente, un mostro narrativo che esige di essere affrontato tutto insieme, con il respiro lungo e lo stomaco forte.
Le cinque parti che compongono il libro funzionano come movimenti sinfonici di un'unica composizione dolorosa. Si comincia con La parte dei critici, dove quattro studiosi europei (Pelletier, Espinoza, Norton e Morini) si muovono tra simposi e letture in cerca del misterioso scrittore tedesco Benno von Archimboldi. Da lì, si passa a La parte di Amalfitano, che racconta il lento disfacimento mentale di un professore cileno trasferito a Santa Teresa, una città immaginaria al confine con il Messico. Segue La parte di Fate, dove un giornalista afroamericano, Quincy Williams detto Fate, viene inviato a Santa Teresa per seguire un incontro di boxe, ma si trova invischiato nell'incubo dei femminicidi. Il cuore nero del romanzo è La parte dei delitti: circa trecento pagine di registrazione minuziosa, quasi burocratica, di omicidi di donne.
Infine, La parte di Archimboldi, che ricostruisce la vita dello scrittore tedesco, dalla giovinezza nella Germania nazista fino alla sua sparizione. Il libro non cerca un centro, ma si costruisce per attrazione e digressione, come se il cuore della narrazione fosse un abisso che si può solo aggirare.
 |
| Roberto Bolaño |
Santa Teresa non è solo un luogo. È un personaggio. È il buco nero del romanzo. Un deserto urbano in cui il tempo si spezza, le logiche collassano, la violenza diventa sistemica e il dolore viene registrato ma non ascoltato. Bolaño non scrive un romanzo d'inchiesta. Scrive un requiem. I delitti sono elencati con uno stile freddo, spoglio, che non cerca l'empatia ma la registrazione impietosa della realtà. Come se il lettore fosse costretto, quasi controvoglia, a guardare l'indicibile.
''La morte e l'oblio erano il pane quotidiano di quella città.''
Il male, in 2666, non ha un volto. Non ha una causa precisa. Non ha una logica. Il vero colpevole sembra essere una civiltà intera, che ha smarrito la capacità di distinguere tra dolore e cronaca, tra morte e statistica, tra etica e convenienza.
''L'inferno è credere che il passato torni. L'inferno è sapere che il passato ritornerà.''
La letteratura, in questo contesto, non salva. I critici che aprono il romanzo sono figure tragicomiche, autoreferenziali, incapaci di affrontare il reale. Archimboldi stesso, lo scrittore fantasma al centro della loro ossessione, è una figura spettrale, più simile a un sopravvissuto che a un genio.
''Scrivere non era altro che un modo per sparire.''
Bolaño sembra suggerire che l'arte non può redimere il mondo, ma solo testimoniarlo. Eppure, proprio in questa impotenza si nasconde una forma estrema di resistenza: continuare a scrivere, a leggere, a raccontare, anche sapendo che non servirà. Fallire ancora. Fallire meglio.
Il corpo attraversa tutto il romanzo: i corpi assassinati a Santa Teresa, i corpi desideranti dei critici, quello stanco di Amalfitano, quello spaesato di Fate, quello silenzioso di Archimboldi. E il tempo, come un deserto, li avvolge. Un tempo che non è lineare, ma circolare, spezzato, come un sogno rotto. Come in Borges, la realtà è un labirinto di specchi. Ma a differenza di Borges, Bolaño non cerca la perfezione: cerca la materia viva, il dettaglio disturbante, il sangue sulla sabbia.
2666 è un romanzo sul potere. Sui suoi linguaggi, le sue omissioni, le sue complicità. I delitti di Santa Teresa sono la manifestazione di un sistema in cui tutto può essere sacrificato: il lavoro, il desiderio, la donna, il povero, l'immigrato.
Bolaño non spiega, non interpreta.
Mostra.
E nel mostrare, accusa.
''Il mondo sta andando verso un posto che non è il futuro, né il passato, né il presente. È solo un posto.''
Leggere 2666 è un'impresa. Richiede tempo, fatica, coraggio. Ma è anche un'esperienza trasformativa. Alla fine del viaggio, ci si accorge che non stavamo cercando Archimboldi, o una spiegazione ai delitti, ma qualcosa di più profondo: un modo per sopravvivere all'assurdo.
''Non capiva. Non capiva nulla. E poi improvvisamente capì. Non le parole, non i significati, non i concetti, ma qualcos'altro. Qualcosa che non aveva nome.''
Benvenuti nella Biblioteca di Babele. Da qui inizia il nostro viaggio.
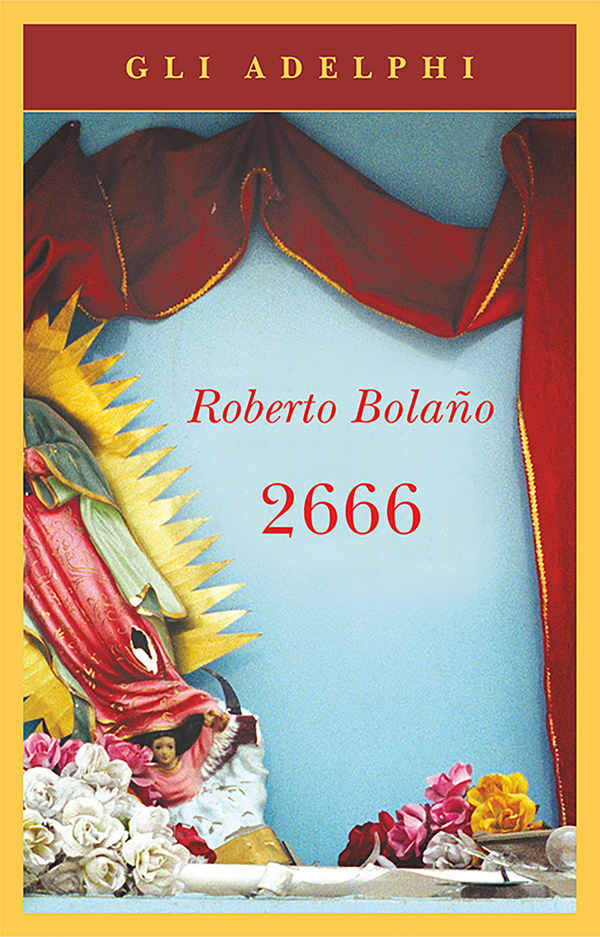



Nessun commento:
Posta un commento