''Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant'' (Dove fanno il deserto, lo chiamano pace)
(Tacito - De Agricola)
C'è un'immagine che più di ogni altra riassume il delirio politico e morale del nostro tempo: Benjamin Netanyahu che porge una lettera a Donald Trump, nella residenza dorata di Mar-a-Lago, candidandolo ufficialmente al Premio Nobel per la pace. È accaduto davvero. È accaduto mentre a Gaza, nello stesso momento, centinaia di migliaia di esseri umani si ammassano in tendopoli di fortuna, senza acqua, senza luce, senza medicine, con le ossa dei morti che spuntano dalla sabbia come ammonimenti biblici. È accaduto mentre l’Occidente civile, quello che si vanta dei suoi valori democratici, voltava lo sguardo o peggio ancora applaudiva.
Netanyahu, con il volto fiero e il sorriso compiaciuto, ha elogiato Trump per il suo “straordinario contributo alla stabilità globale”.
Lo ha fatto nel pieno di un’offensiva militare su Gaza che ha già ucciso più di 57.000 persone, secondo le stime di diverse agenzie internazionali, un numero che include migliaia di donne e bambini. In una guerra che ha visto l’esercito israeliano radere al suolo ospedali, scuole, centrali elettriche e impianti idrici, in aperta violazione del diritto internazionale umanitario.
In uno scenario dove la Corte Penale Internazionale ha già emesso mandati d’arresto contro lo stesso Netanyahu, accusandolo di crimini di guerra, crimini contro l’umanità e uso deliberato della fame come arma.
E mentre accade tutto questo, ecco che l’uomo al centro di questa carneficina propone Trump, il presidente che ha trasferito l’ambasciata americana a Gerusalemme scatenando un’escalation di tensione, che ha tagliato i fondi all’UNRWA, che ha bombardato l’Iran e ha appoggiato senza riserve la linea più dura di Tel Aviv, come degno erede di Martin Luther King, Desmond Tutu, Elie Wiesel e Malala. Una farsa tragica, una sceneggiatura distopica in cui i ruoli sono rovesciati.
La motivazione ufficiale cita gli Accordi di Abramo, firmati nel 2020 da Israele con Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Sudan e Marocco, con la regia dell’amministrazione Trump.
Ma basterà leggere i rapporti delle ONG per capire che si tratta di normalizzazioni diplomatiche tra élite autoritarie, spesso imposte con incentivi economici o forniture militari, e che nulla hanno a che vedere con la pace tra i popoli.
I palestinesi non sono neanche stati consultati.
Anzi, quegli accordi sono stati per loro l’ennesima conferma del tradimento, dell’isolamento, della negazione storica di ogni diritto.
Lungi dal pacificare, hanno rafforzato il blocco sunnita anti-iraniano e accelerato la corsa agli armamenti nell’area. Nel momento in cui Netanyahu loda quegli accordi come prova di ''leadership coraggiosa'' da parte di Trump, dimentica o forse finge di dimenticare che quello stesso Trump ha promosso l’annessione di territori occupati, ha bloccato qualsiasi mediazione internazionale con i palestinesi e ha incoraggiato apertamente l’estrema destra israeliana.
È il linguaggio orwelliano della diplomazia perversa: si definisce ''pace'' la complicità con l’apartheid, si chiama ''stabilità'' l’eliminazione del nemico, si chiama ''riconoscimento'' l’acquisto del silenzio altrui.
Ma non è finita.
Durante lo stesso incontro, Trump e Netanyahu hanno discusso apertamente un ''piano per il futuro di Gaza'' che, secondo alcune fonti, prevederebbe il reinsediamento forzato di milioni di palestinesi in altri Paesi, con il supporto logistico americano.
Un’operazione che sarebbe imposta militarmente e travestita da ''riqualificazione urbanistica'', con Gaza che, come già precedentemente ipotizzato dallo stesso Trump, verrebbe trasformata in una sorta di hub del turismo mediorientale, una nuova ''Singapore sul Mediterraneo'', come qualcuno l’ha definita con un ghigno.
In altre parole: espulsione, colonizzazione, esproprio, rimozione fisica del popolo che da decenni resiste a un’occupazione illegittima. Amnesty International ha parlato di un progetto che viola tutte le convenzioni internazionali e che potrebbe configurarsi come pulizia etnica.
L’ONU ha reagito con una dichiarazione secca: ''La deportazione forzata di civili è un crimine di guerra''. Eppure, in questo contesto, Netanyahu non solo propone Trump per il Nobel, ma si presenta anche come l’artefice di una ''nuova visione di pace''. La stessa pace che Publio Cornelio Tacito, nel suo De Agricola, fa pronunciare al generale calèdone Calgaco, quando cerca di infondere coraggio alle sue truppe prima della battaglia del monte Graupio contro l'esercito romano, con un discorso in cui delinea un'unica alternativa di fronte ai romani, insaziabili dominatori: o libertà o morte.
''Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant" (dove fanno il deserto, lo chiamano pace).
Siamo dunque all’apoteosi del paradosso: un premier accusato di crimini contro l’umanità che propone per il massimo riconoscimento etico un presidente condannato per istigazione all’insurrezione e evasione fiscale. Un duo che ha fatto del cinismo una dottrina, della propaganda una scienza e della violenza una strategia.
Una pantomima macabra, in cui il Premio Nobel, nato per celebrare chi si è battuto contro le guerre, viene prostituito per finalità elettorali, come moneta di scambio tra due leader politicamente fragili, entrambi sotto processo e in cerca di riabilitazione.
Una pantomima che offende la memoria di chi ha davvero sacrificato la propria vita per la pace: da Gandhi a Sadat, dal palestinese Arafat all'israeliano Yitzhak Rabin. Ma soprattutto, una pantomima che oscura la verità quotidiana di chi oggi muore sotto le bombe, senza voce, senza telecamere, senza Nobel.
E se qualcuno pensa che questa sia solo una provocazione simbolica, un gioco diplomatico senza conseguenze, basta osservare l’effetto domino che ha già prodotto.
Dopo Netanyahu, anche il Pakistan, notoriamente antiamericano, ha proposto Trump per il Nobel, rivelando quanto sia malleabile la verità politica e quanto conti, oggi, solo la sopravvivenza geopolitica. La Norvegia, paese ospitante del Comitato per il Nobel, ha espresso preoccupazione ma non ha ancora preso una posizione netta.
Intanto, nei social e nelle piazze del mondo arabo, la notizia è stata accolta con rabbia, sdegno, risate amare. Decine di vignette circolano con l’immagine di Trump vestito da crociato, o in posa alla Nobel Lecture mentre sullo sfondo scoppiano bombe e bruciano corpi. L’ipocrisia è diventata talmente manifesta da rasentare la pornografia morale.
La verità è che viviamo in un’epoca in cui i premi non premiano più chi merita, ma chi vince. In cui il linguaggio è stato rovesciato: la guerra è umanitaria, la deportazione è sviluppo, la repressione è ordine, la propaganda è informazione.
E allora sì, il paragone che evoca Hitler che propone Reinhard Heydrich, l'organizzatore della "soluzione finale", per il Nobel, non è più solo una provocazione grottesca. È una diagnosi storica. Quando gli assassini si travestono da pacificatori, quando la pace viene usata come una clava per giustificare la guerra, quando la verità non è più uno strumento di giustizia ma un’arma narrativa, allora siamo entrati nel buio.
E da quel buio si esce solo con un urlo.
Forte, scomodo, inascoltato.
Ma necessario.

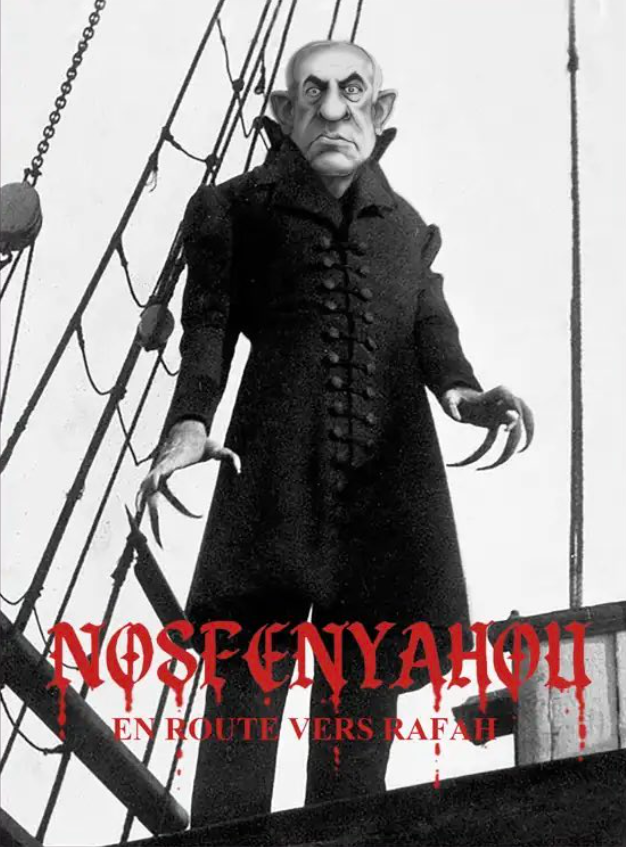




Nessun commento:
Posta un commento