C'è un momento in cui le cose si incastrano.
Un momento in cui tutto sembra tornare, e gli eventi del passato, le coincidenze casuali, le cifre nascoste, i simboli sepolti nella polvere del tempo si legano come anelli di una catena.
Il mondo si dispone secondo un ordine segreto e ineluttabile.
Il cuore accelera, l'illuminazione incombe, e l'uomo sente di avere compreso. Ma non è la verità ciò che ha colto.
È il delirio.
In questo buco nero semiotico affonda Il Pendolo di Foucault (1988), romanzo fiume, gioco vertiginoso, saggio mascherato da thriller, o forse il contrario. Una trappola epistemologica costruita con pazienza enciclopedica da Umberto Eco, filosofo, semiologo, bibliofilo, narratore mai ingenuo. Un'opera che anticipa di trent'anni i deliri di QAnon, la bulimia digitale delle teorie cospirazioniste, l'equivalenza tra "tutto si tiene" e "niente ha senso".
Rileggere oggi Il Pendolo di Foucault è come aprire un grimorio nel mezzo di una pandemia informativa.
Protagonisti del romanzo sono tre redattori editoriali: Casaubon (che narra la vicenda), Belbo e Diotallevi. Tre uomini colti, disillusi, abituati a trattare con autori di saggi esoterici e teorie alternative. Da un gioco intellettuale nasce il "Piano": un collegamento fittizio tra i Templari e ogni altra setta, complotto, ordine misterico nella storia dell'Occidente. Una storia segreta del mondo, dal Medioevo fino al presente, in cui ogni dettaglio è codificato, ogni nome celato, ogni luogo segnato da un'eco di verità antica.
Il gioco, però, sfugge loro di mano. Qualcuno comincia a prenderlo sul serio.
Qualcuno comincia a crederci.
Il Pendolo di Foucault è un romanzo su ciò che accade quando la mente, disabituata al dubbio, confonde la struttura col significato.
Il Piano è il vero protagonista del romanzo. E non è solo una finzione: è un virus. Un'ossessione. Una malattia della mente e del senso.
 |
| Il Pendolo di Foucalt |
Il romanzo è un labirinto strutturale.
Diviso in dieci sezioni (come le dieci sephiroth della Cabala), è disseminato di riferimenti colti, rimandi esoterici, documenti inventati e reali. Il lettore viene invitato a entrare in un mondo parallelo in cui ogni citazione è sospetta, ogni nome ha un doppio fondo, ogni frase è una trappola per topi intellettuali.
Umberto Eco, che non crede al "profondo" come luogo di salvezza, scava nel delirio degli interpreti. Ma lo fa con amore. Gli eruditi pazzi, gli occultisti sgrammaticati, i decodificatori compulsivi, sono le caricature di un male contemporaneo: la convinzione che la verità sia sempre nascosta, che tutto sia simbolo, che l'apparenza sia sempre menzogna.
Il pendolo che dà il titolo al romanzo è quello di Léon Foucault, installato al Conservatoire des Arts et Métiers di Parigi (una copia è installata al Pantheon ndr.). È un oggetto reale, concreto, ma è anche simbolo.
Del centro immobile.
Dell'ordine eterno.
Di un universo che si muove ma è fondato su un principio fisso.
Il pendolo è ciò che manca ai personaggi: un punto di riferimento non arbitrario, un principio non interpretabile.
Ma non esiste. O meglio: esiste, ma è inaccessibile al linguaggio.
Allora non resta che il gioco.
Un gioco che degenera. Che assorbe tutto. Che produce la propria realtà.
Come ogni teoria del complotto: più la smonti, più si rafforza. Il Piano, come il pendolo, diventa ipnosi.
La grande intuizione del romanzo è che il bisogno di trovare un ordine può trasformarsi in paranoia. Che la sete di conoscenza, se non accompagnata dal dubbio, si rovescia in superstizione. La mappa non è il territorio, ma a volte diventa più potente. I protagonisti, da redattori ironici, diventano interpreti seri. Perdono la distanza. L'ironia si frantuma. Il linguaggio diventa una trappola.
In questo senso, Eco smonta anche il suo precedente Il nome della rosa. Lì, la verità era possibile, benché tragica.
Qui invece la verità non esiste.
Esiste solo l'ossessione per essa. L'epistemologia del complotto sostituisce la ricerca con la costruzione. Ciò che si cerca, si crea. Come la divinità gnostica che si specchia e genera il mondo.
 |
| Umberto Eco |
Il romanzo è anche una critica alla cultura del sospetto, quella che si nutre di interpretazioni infinite, di decostruzioni compulsive, di senso ovunque e comunque. Un certo postmodernismo mal digerito, che ha trasformato ogni testo in un campo minato. Eco, semiologo per professione, ci avverte: non tutto è segno. E non tutti i segni dicono qualcosa. C'è un limite oltre il quale l'interpretazione è violenza.
Il pendolo oscilla. Ma non indica.
Nel 1988, il web non esisteva ancora. Ma Il Pendolo di Foucault è un romanzo che anticipa la rete. La sua struttura è ipertestuale. Le informazioni si moltiplicano senza gerarchia. Il lettore è costretto a saltare, connettere, ricostruire. Come accade oggi in rete: Wikipedia, Reddit, YouTube, blog cospirazionisti. Là dove l'accumulo diventa sistema. Dove l'enciclopedia si trasforma in ideologia.
Eco sembra suggerire: non è la mancanza di informazione il problema, ma il suo eccesso. L'infodemia. Il rumore. Il delirio di connessione. Il Piano, come ogni algoritmo impazzito, non si può spegnere. Perché è dentro di noi.
Tra i tre protagonisti, Belbo è il più tragico. Il più umano. Scrive, ma non pubblica. Archivia i suoi pensieri in un computer chiamato Abulafia. La scrittura, per lui, è un modo per resistere alla dissoluzione. Ma anche una forma di autoipnosi. Belbo è il moderno scrivano, lo scrittore senza lettore, l'uomo che affida al codice il proprio fallimento esistenziale.
Belbo è la memoria fallace del secolo. L'intellettuale che ha perso la fede nella verità ma continua a cercarla. Ma invece di Dio, trova il Pendolo.
Oggi il Piano è ovunque. Non c'è bisogno dei Templari. Bastano i vaccini, il 5G, il gender, Soros, le scie chimiche. Il meccanismo è lo stesso: collegare tutto. Eliminare il caso. Rifiutare l'ambiguità. Costruire una narrazione totalizzante che dia un senso a ciò che non ne ha. Il complotto è la teodicea dei tempi secolarizzati.
Eco lo aveva capito. Anzi: lo aveva mappato. Con ironia, con amore per l'erudizione, ma senza indulgenza. Il Pendolo di Foucalt non è solo un romanzo. È un vaccino letterario contro l'epidemia del senso.
Ma come ogni vaccino, funziona solo se accetti di metterti in discussione.
Il Pendolo di Foucault è anche una biblioteca. Contiene testi reali, inventati, semi-inventati. Citazioni vere e apocrife. Documenti medievali e manuali da edicola.
È un archivio impossibile, come quello immaginato da Borges. Ma invece di essere infinito, è inesauribile.
Ogni lettura genera una nuova interpretazione.
Ogni rilettura è un nuovo ingresso nel labirinto.
La cultura occidentale è qui trattata come una rete senza centro, un insieme di segni che si rispecchiano. Non c'è verità da trovare, solo narrazioni da disinnescare.
Il pendolo non indica la direzione: segna il tempo che ci resta.
In un tempo in cui ogni assurdità trova spazio, rilievo, eco digitale, rileggere Il Pendolo di Foucault significa fare un atto di resistenza intellettuale. Accettare che la verità non è sempre nascosta. Che il caso esiste. Che il mondo non è un romanzo. Ma che la letteratura può ancora salvarci: non offrendoci risposte, ma insegnandoci il gusto del dubbio.
Eco ci ha lasciato una mappa che non porta a nessun tesoro. E proprio per questo è preziosa.
Perché ci ricorda che il compito dell'intelligenza non è credere, ma comprendere.
E che comprendere significa, spesso, non crederci troppo.
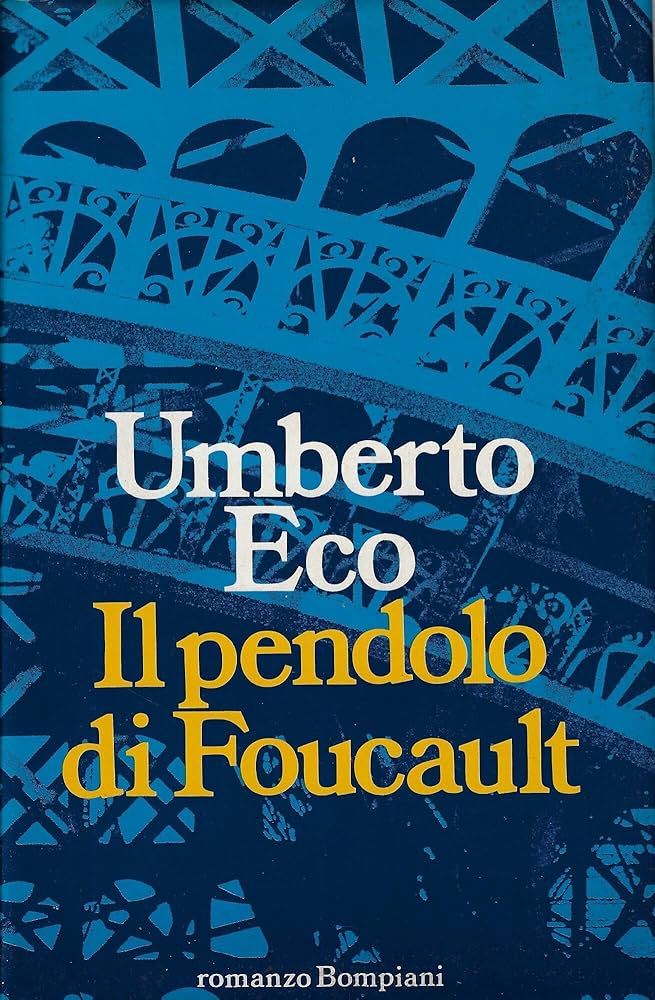


Nessun commento:
Posta un commento